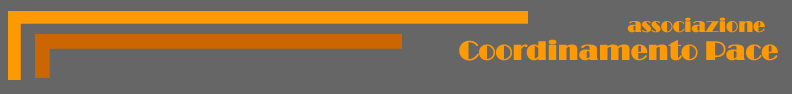| |
ITALIA/ PACS E ABORTO: IL PAPA A GAMBA
TESA
Il Manifesto, 13 gennaio 2006 di Gianni Rossi Barilli
Se si voleva
un'altra dimostrazione del fatto che la chiesa cattolica è la madre,
o perlomeno la zia, di ogni autoritarismo e totalitarismo d'occidente, eccola
qua. Con il diabolico tempismo di Benedetto XVI che entra a gamba tesa, da
sotto la fluente sottana, nel dibattito politico italiano.
Ma l'Italia laica non si è rassegnata.
Sabato 14 gennaio 2006 le donne e gli uomini italiani, hanno dato una grande risposta. Manifestazioni di eccezionale grandezza ed intensità si sono tenute a Milano (donne di tutte le età, e con loro molti uomini, sono USCITE DAL SILENZIO a difesa della legge 194 e del diritto/libertà delle donne nella gestione della propria vita, della propria sessualità, del proprio corpo), e a Roma (a sostegno dei PACS, cioè riconoscimento di diritti primari ai cittadini e alle cittadine che per ragioni diverse - per scelta o per impedimento - formano una famiglia fuori dall'istituto del matrimonio).
(Coordinamento Pace)
Alla vigilia di
due manifestazioni che chiedono di diradare l'insopportabile cappa clericale
gravante sulla nostra vita pubblica e sulle nostre esistenze individuali (l'una
a Milano a difesa della legge 194 e della libertà femminile, l'altra
a Roma sostegno della legge sulle unioni civili per le coppie di fatto), il
papa usa la propria voce soave per un attacco all'arma bianca.>
No alla RU
486, dice Ratzinger, perché l'aborto altrimenti diventerebbe troppo
facile per femmine peccatrici che al contrario meritano di soffrire il più
possibile per le proprie dissennate scelte. E no al riconoscimento giuridico
di forme di famiglia differenti da quella consacrata nel matrimonio eterosessuale,
perché ciò oscurerebbe il valore immutabile della famiglia tradizionale.
Dato che
i Pacs, come si è ripetuto fino alla nausea, non comportano affatto
la richiesta di abolizione del matrimonio tradizionale e non impedirebbero
ai cattolici di continuare a vivere cattolicamente il loro concetto di famiglia,
è chiaro come il sole che il fuoco di sbarramento papale è tipica
espressione di una mentalità totalitaria incompatibile con la moderna
convivenza civile. È precisamente il rifiuto di accettare che sia concesso
il benché minimo diritto positivo a coloro che si collocano al di fuori
delle ferree norme stabilite grazie a secoli di arbitrio e violenza contro
i «diversi» e le «diverse», promosse in prima persona
dalla chiesa cattolica. Tanto più che di queste concessioni, aggiunge
Benedetto, non si sente alcuna necessità sociale. Detto da chi per
contratto può vivere in famiglia con tutte le persone dello stesso
sesso che vuole suona un po' maramaldesco.
Ancora più
di questo, tuttavia, spiacciono i sorrisi senza la minima increspatura e i
salamelecchi tributati ieri al santo padre dagli immediati destinatari della
sua arringa. Vale a dire il sindaco di Roma Walter Veltroni, il presidente
della provincia Enrico Gasbarra e il presidente della regione Lazio Piero
Marrazzo. Passi pure, anche se non torna a suo merito democratico, per il
«margheritino» e cattolico Enrico Gasbarra. Ma per Veltroni e
Marrazzo proprio no, visto che il primo è esponente di primo piano
dei democratici di sinistra, promotori ufficiali della proposta di legge sui
Pacs (approvata addirittura all'unanimità all'ultimo congresso del
partito), e che il secondo si è impegnato nelle scorse settimane a
modificare la normativa regionale fatta approvare dal suo predecessore Storace
per escludere le coppie «irregolari» dal diritto all'assistenza
riservato alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Le esigenze della
diplomazia si sono evidentemente imposte in questo caso sulle convinzioni
personali.
Non c'era
comunque alcuna esigenza di questo tipo per i tg Rai che (tg3 incluso) hanno
dato la notizia del nuovo anatema papale all'ora di pranzo senza farla seguire
da neppure un secondo di informazione sul dissenso di chi la pensa diversamente
da Benedetto XVI. Il che non fa ben sperare sul buon esito della richiesta
di trasmettere in diretta le manifestazioni di sabato a Milano e Roma presentata
ufficialmente ieri alla Rai da oltre 60 parlamentari. Non ci resta quindi
che porgere l'altra guancia, sperando che almeno di questo il papa rimanga
contento.
torna all'inizio della pagina

|
|
| |
RAPPORTO ANNUALE SULLE DIECI CRISI UMANITARIE DIMENTICATE
Medici Senza Frontiere, 12 gennaio 2006
La lista delle dieci crisi umanitarie più
ignorate dalle TV è stata realizzata dalla sezione statunitense di
Medici Senza Frontiere, che ha analizzato lo spazio dedicato dai telegiornali
serali di tre importanti network alle crisi umanitarie nel corso del 2005.
Da questa analisi è emerso che, se in generale poco spazio è
stato dedicato alle crisi umanitarie dai telegiornali, dieci crisi sono state
particolarmente ignorate, conquistandosi così un posto nella "Top
ten delle Crisi Più Ignorate". Si tratta del conflitto e dell'emergenza
sanitaria in Repubblica Democratica del Congo; del conflitto in Cecenia; della
violenza ad Haiti; dell'assenza di ricerca per combattere l'HIV / AIDS nei
paesi poveri; degli scontri religiosi ed etnici nell'India Nord-Orientale;
dell'emergenza umanitaria che continua in Sud Sudan anche dopo la cessazione
ufficiale delle ostilità; della situazione di anarchia e conflitto
che martoria la Somalia da oltre vent'anni; della guerriglia in Colombia;
dell'insicurezza in Nord Uganda; della crisi in Costa d'Avorio.
La situazione nei TG italiani: diminuisce ancora l'attenzione dedicata alle
crisi umanitarie
Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, Medici Senza Frontiere
ha presentato il secondo rapporto dell'Osservatorio Crisi Dimenticate: un'iniziativa
in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che ha effettuato un'analisi
qualitativa e quantitativa dello spazio che le principali edizioni (pranzo
/ sera) dei TG nazionali di RAI, Mediaset e La7 hanno dedicato alle emergenze
umanitarie nel corso del 2005.
Dall'analisi dell'Osservatorio Crisi Dimenticate si evince che i TG nazionali
hanno dedicato alle emergenze umanitarie nel loro insieme circa 293 ore su
un totale di 2'539 ore di programmazione, ovvero l'11,6% dello spazio –
un dato in netta diminuzione rispetto al secondo semestre del 2004, quando
lo spazio era stato il 17,5%.
Così come lo scorso anno, anche quest'anno la crisi irachena risulta
la più seguita dai TG di pranzo e sera (136 ore, cioè il 46%
del tempo dedicato alle emergenze internazionali); tuttavia, è anche
evidente che di queste 136 ore, la stragrande maggioranza del tempo è
stata dedicata a sequestri eccellenti (50 ore circa), alla politica italiana
(12 ore) e a quella USA (5 ore), al processo a Saddam (quasi 4 ore), mentre
lo spazio dedicato a informare gli Italiani sulla situazione umanitaria della
popolazione civile e sui suoi bisogni si riduce a 24 minuti (0,3%) dedicati
agli aiuti umanitari, 5 minuti dedicati ai profughi (0,1%) e 4 minuti dedicati
ai civili vittime di guerra.
La seconda crisi più seguita dai TG italiani è stata quello
dello Tsunami, per la quale si può constatare un'attenzione primaria
nei confronti delle vittime, degli aiuti umanitari e della situazione nei
paesi colpiti, che dimostra un giornalismo attento alle sorti delle vittime,
qualcosa di tanto encomiabile quanto raro.
La terza crisi più seguita dai media italiani è stato il conflitto
israelo-palestinese, cui sono state dedicate oltre 39 ore (di cui un solo
minuto dedicato agli aiuti umanitari).
Entrando poi nel dettaglio delle dieci crisi umanitarie più ignorate,
anche nei nostri TG queste hanno trovato poco spazio:
· 1 ora e 37 minuti al fenomeno AIDS in generale (di cui 1 solo minuto
dedicato alla lotta all'AIDS in Africa);
· 1 ora e 24 minuti dedicati alla Somalia (di cui 2 soli minuti sono
stati dedicati agli scontri e alle tensioni che affliggono la popolazione
civile);
· 48 minuti dedicati alla crisi in Cecenia;
· 28 minuti alla situazione in Colombia;
· 21 minuti ad Haiti, ma solamente al sequestro lampo di una donna
di origine italiana;
· 8 minuti alla guerra in Congo;
· 7 minuti alla situazione in Sud Sudan;
· 4 minuti alla guerra in Uganda;
· 0 minuti ai conflitti interreligiosi in India nord-orientale;
· 0 minuti alla situazione in Costa d'Avorio.
Pochissimo spazio è stato inoltre dedicato ad altre gravi crisi umanitarie:
· poco più di un'ora alla tragedia del Darfur, dove due milioni
di sfollati continuano a vivere in una condizione di estrema precarietà,
sottoposte a violenze e tensioni permanenti.
· sei minuti all'epidemia di malaria, che ogni anno provoca oltre un
milione di morti;
· due minuti alla situazione in Angola e a quella in Zimbabwe.
Una peculiarità italiana è rappresentata dal fatto che i nostri
TG hanno anche ignorato crisi che, al contrario, grande risonanza hanno avuto
a livello internazionale: è il caso della crisi nutrizionale in Niger
, con oltre 60.000 bambini gravemente malnutriti assistiti da MSF, alla quale
i nostri TG hanno dedicato solo 31 minuti. E sebbene i nostri telegiornali
abbiano dedicato quattro ore e mezzo al terremoto in Pakistan all'inizio di
ottobre , queste appaiono esigue di fronte a un disastro che ha provocato
oltre 73'000 morti e due milioni e mezzo di senzatetto; già dopo un
paio di settimane la notizia era sparita dai nostri teleschermi, mentre i
media di tutto il mondo ancora a dicembre seguivano con angoscia la sorte
dei sopravvissuti che dovevano affrontare il terribile inverno privi di ripari
Scarica
il rapporto da www.medicisenzafrontiere.it
torna all'inizio della pagina

|
|
| |
COME
SAI SE TI STANNO MILITARIZZANDO? ALCUNI INDIZI FEMMINISTI
Una lezione di Cynthia Enloe all'Università
di Toronto.
29 marzo 2006, a cura dello staff di Whr net. (trad. M.G. Di Rienzo)
Come si può modellare
ciò che le donne fanno "naturalmente"? Come si può
mantenere bassi i salari basandosi sull'ideologia della "figlia obbediente"?
E tu, come puoi dire se ti stanno militarizzando?
Queste sono le domande
che la scienziata Cynthia Enloe si è posta durante la sua lezione all'Università
di Toronto. Attraverso le sue ricerche, la professoressa Enloe ha mostrato
che non sono solo i governi ad avere un ruolo nel modellare la "naturalità"
rispetto a ciò che le donne possono fare, ma che in questo campo agiscono
le scuole, le compagnie commerciali, le chiese e le famiglie. Enloe ha anche
apprezzato molto, durante le sue ricerche, la resistenza che donne e ragazze
oppongono agli interessi delle istituzioni sunnominate: è molto più
difficile di quanto sembri indurle a fare ciò che esse vogliono. Questa
difficoltà, lei dice, parla del potere Sottostimato delle donne, potere
che si rivela quando gli si pongono domande femministe.
Un esempio che la professoressa ha fornito della manipolazione del comportamento
femminile è la creazione del mito della "figlia obbediente"
nella Corea del Sud durante gli anni '50. Questo mito fu creato per persuadere
le madri ed i padri che le ragazze avrebbero mantenuto la propria rispettabilità
solo se si fossero recate a Seoul per lavorare nelle fabbriche di indumenti
e di elementi elettronici: tale era infatti il loro dovere come figlie. L'idea
era stata creata e propagandata dal governo sudcoreano, perciò non
vi era nulla di naturale nella "figlia obbediente" che lavora in
fabbrica, si trattava di una semplice manipolazione per fini economici. Ad
ogni modo, ci volle molta persuasione ideologica per passare la nozione della
"figlia obbediente" come pilastro di quello che sarebbe divenuto
il "miracolo economico" della Corea del Sud.
Enloe ha detto di essere rimasta colpita da quanto pervasiva sia la militarizzazione,
non limitandosi alle ovvie branche dell'industria, della mascolinità
o della politica estera: secondo lei è possibile militarizzare cose
che a prima vista non sembrano avere con il militarismo una
connessione ovvia, come la moda, o l'idea di una "buona moglie",
la tua città natale, la narrativa, o una persona Il processo di militarizzazione
può svolgersi per passi così piccoli ed insidiosi che dapprima
non riusciamo a riconoscerlo. Quando qualcosa viene militarizzato, esso diventa
sempre più dipendente dall'esercito o da idee militariste, da senso
di stretta appartenenza o di "normalità" nella cultura popolare,
e dall'insicurezza. Si può militarizzare qualunque cosa incoraggiando
la dipendenza, nelle persone, ad aspirazioni che in se stesse non appaiono
militarizzate. Tu puoi voler essere elegante, fare un buon matrimonio, essere
accettata dalla tua comunità, o essere presa sul serio sul lavoro:
tutte queste aspirazioni possono essere autenticamente tue, ma la loro realizzazione
può dipendere da quanto hai acquisito delle idee militariste.
La militarizzazione avviene su livelli molteplici. Uno di essi è l'ideologia,
che Enloe ha definito come composta da credenze e valori.
L'ideologia imbeve la coscienza di una società e quando si tratta di
un'ideologia militarizzata i pericoli che crea sono molti. Ciò che
serve per resistere alla militarizzazione e fermarla è un cambiamento
nelle idee e nei comportamenti.
La maggioranza delle persone
che vengono "militarizzate" non fanno parte di eserciti, e possono
aver attraversato un processo di militarizzazione assai lento, per cui non
sono in grado di riconoscerlo o di pensare a se stesse in questo modo. Si
definiranno invece razionali, "terra terra" o realistiche.
Il militarismo è un sistema di idee, la militarizzazione è un
processo sottile, che lavora in crescendo ed include l'accettazione dei seguenti
assunti:
1. Il mondo è un posto pericoloso, a priori. A seconda dell'estensione
di tale pensiero, la persona apre più o meno la propria porta per essere
militarizzata. Quest'idea e la paura che ne risulta sono propagandate dai
militaristi. Ad ogni modo, molte persone possono legittimamente pensare che
il proprio mondo sia un posto pericoloso (ad esempio se vivono in una casa
in cui vengono abusate) e questo non le espone automaticamente alla militarizzazione.
2. E' naturale o
logico avere nemici.
3. C'è un
modo gerarchico di organizzarsi che ha più senso di tutti gli altri,
ed è il modo più efficiente di fare le cose.
4. E' "naturale" dividere il mondo fra "protettori" e
"protetti", il che basa pesantemente sulle idee di mascolinità
e di femminilità. Se si
pensa che sia naturale dividere il mondo in questo modo, è molto difficile
che la divisione non avvenga per linee di genere.
5. Avere un esercito è un segno di maturità per uno stato, non
averlo induce seri dubbi su tale maturità.
Un esempio di quest'ultimo
punto è la storia di come Aristide prese il potere ad Haiti, con l'ingente
aiuto dell'esercito statunitense. Aristide considerava il Costa Rica come
un modello per la riorganizzazione della struttura sociale del suo paese.
Il Costa Rica aveva sciolto il suo
esercito, in parte come strategia per maneggiare le dispute con il paese confinante,
El Salvador. Ma gli Usa si opposero all'idea, e convinsero Aristide che Haiti
non sarebbe stato preso sul serio nella comunità internazionale se
non avesse avuto un esercito. La nozione che ci sia bisogno di un esercito
credibile (ben finanziato, moderno, eccetera) per avere una rappresentanza
negli affari esteri, e che il governo e la popolazione debbano sostenere tale
esercito ed essere pronti ad usarlo, è quella che prevale nel mondo
odierno. Un altro esempio è il linguaggio usato per incoraggiare i
giapponesi a sbarazzarsi dell'art. 9 della loro Costituzione, che non permetteva
loro di formare un esercito. Il Giappone si è trovato sotto pressione
da parte degli Usa e di altri paesi, i quali sostengono che se il Giappone
vuole far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU deve ricostruire il proprio
esercito.
La professoressa
Enloe ha fatto notare che avere una o due delle credenze suddette è
Abbastanza comune, e che non necessariamente ciò conduce alla militarizzazione
della persona: il pericolo arriva quando si crede all'intero "pacchetto".
Il passo successivo per
Enloe è stato aggiungere una curiosità femminista alla ricerca
e chiedersi cosa un'analisi femminista avrebbe aggiunto e cosa altrimenti
avremmo omesso di vedere. Il lavoro più interessante in questo senso
è stato fatto dalle femministe di Belgrado, Tel Aviv, Istanbul,
Sudafrica, Congo e Cile.
La prima domanda
femminista della professoressa riguardava i gruppi di donne sposate a militari
di professione. La ricerca rivelò che i governi ed i ministeri della
difesa provavano molta ansia rispetto a queste donne.
Costoro non facevano
"naturalmente" le cose di cui i mariti militari avevano bisogno,
e non diventavano automaticamente militarizzate, perciò i governi investivano
notevoli energie per assicurarsi che lo fossero.
Un esempio di resistenza
e sfida alla militarizzazione viene dalle mogli di militari di stanza alla
base di "Red Deer", Alberta. Negli anni '80 esse si organizzarono
al fine di ottenere miglior assistenza sanitaria per le famiglie dei militari
di professione. La richiesta incontrò la resistenza delle autorità
che fecero pressione sugli uomini affinché "controllassero le
loro mogli". Le donne capirono subito che l'esercito non prevedeva uno
spazio per loro come attiviste civili, ed il chiaro messaggio che ricevettero
diceva loro di ritenersi parte della "famiglia dell'esercito" dove
ci si aspettava che esse si conformassero agli ideali militari.
Guidate da Lucie Laliberté,
esse fondarono l'Organizzazione delle mogli di membri dell'esercito, che denunciò
le ideologie militariste e le pratiche dannose di cui le mogli facevano le
spese. Lucie Laliberté fu anche la co-autrice del libro "Nessuna
vita così", che esponeva il modo in cui le
forze armate dipendono dagli invisibili e non retribuiti sforzi delle mogli
dei soldati per il buon funzionamento delle loro operazioni.
Le prostitute sono un
altro gruppo di donne di cui l'esercito ha bisogno.
Ogni operazione militare
ha una diversa relazione con l'economia della prostituzione. Anche se non
sappiamo ancora abbastanza delle relazioni fra gli insediamenti militari in
Iraq o Afganistan e la prostituzione, abbiamo invece una gran quantità
di informazioni sul rapporto fra l'esercito e le
"donne di conforto" o le prostitute in luoghi come Corea del Sud,
Guam, Okanogan e Filippine. Il termine usato nel linguaggio militare per la
prostituzione è "fraternizzazione", il che include tutte
le relazioni che il personale in uniforme ha con i civili locali. Gli insediamenti
militari in Iraq ed Afganistan sono al momento sotto la regola della non-fraternizzazione,
mentre in Bosnia vi sono alcuni contingenti che fraternizzano, ed altri no.
Le regole riguardanti la fraternizzazione sono state sessualizzate grazie
al presupposto di una sessualità maschile soggetta ad impulsi che devono
essere soddisfatti, e se non possono esserlo in maniera legale verranno comunque
soddisfatti in maniera illegale. Questo tipo di logica postula che al fine
di prevenire lo stupro di donne "innocenti" e "buone",
dovuto alla sproporzionata percentuale di uomini rispetto alle donne negli
eserciti, bisogna provvedere servizi sessuali alle forze maschili.
Un terzo gruppo significativo
sono le madri del personale militare, e qui gli sforzi sono tesi a modellare
queste donne nella perfetta "madre del soldato". Si tratta di una
madre che incorpora le nozioni di orgoglio patriottico e di sacrificio patriottico,
che fa la sua parte per il suo paese, che dà alto valore alla gerarchia
ed alla disciplina, eccetera.
L'esercito fa anche appello
agli incentivi economici, che le madri possono valutare come positivi per
il proprio figlio o figlia. Ma in realtà le madri resistono alla seduzione
economica di per se stessa, e perciò gli eserciti tendono a lanciare
campagne pubblicitarie mirate a militarizzare le loro attitudini.
Un esempio di questa tendenza è lo spot pubblicitario diretto alle
donne della comunità afroamericana negli Usa, uno spot che andando
in onda alle 2 del pomeriggio è ovviamente pensato per le casalinghe.
Il filmino, che dura trenta secondi, mostra come prima immagine quella di
una donna di colore, di mezza età, in una cucina. Suo figlio entra
nella stanza e annuncia:
"Mamma, penso di
aver trovato il modo in cui possiamo avere i soldi per farmi frequentare la
scuola di medicina. Oggi a scuola sono venuti i reclutatori dell'esercito."
La donna non reagisce
positivamente alla notizia, e sembra anzi preoccupata, ma il giovane continua:
"E' ora che io diventi un uomo." Lo spot gioca chiaramente sull'aspirazione
all'istruzione, e risponde allo scetticismo materno con la nozione di una
mascolinità militarizzata, tentando di modellare le aspirazioni delle
madri rispetto ai propri figli.
La professoressa
Enloe dice che esempi come questo mostrano quanti sforzi ci vogliano per riuscire
a militarizzare le donne e che in nessun modo si tratta di un compito facile.
La militarizzazione può provvedere alle persone senso di appartenenza,
orgoglio e credibilità, ma è sempre oppressiva e si collega
direttamente alla cooptazione ed alla complicità.
torna all'inizio della pagina

|
|
| |
USA: L'INFLUENZA
DELLA LOBBY ISRAELIANA
Marina Forti, da “il manifesto”, 26 marzo 2006
L'articolo ha già suscitato grandi polemiche
negli Stati Uniti (e ancora di più in Israele), anche se nessuna rivista
americana l'ha pubblicato. Si intitola The Israel Lobby and Us Foreign Policy
(“La lobby israeliana e la politica estera degli Stati uniti”),
di John Mearsheimer della University of Chicago e Stephen Walt della John
F.Kennedy School of Government dell'Università di Harvard. Parte da
una domanda: “Perché gli Usa hanno messo da parte la
propria sicurezza e quella di molti dei loro alleati per promuovere gli interessi
di un altro stato?”.
La risposta, argomentata in 83 pagine, è la profonda influenza dei
gruppi di pressione filo-israeliani negli Usa sulla politica estera americana.
L'articolo è sul sito web dell'università di Harvard, tra i
“working papers”; dopo le prime furibonde reazioni di gruppi filo
israeliani l'università ha aggiunto una postilla: “Le opinioni
espresse impegnano solo gli autori”. Una versione breve è comparsa
il 23 marzo sulla London Review of Books (www.lrb.co.uk).
L'articolo capovolge l'idea corrente che Israele e Washington sono alleati
perché condividono la minaccia del terrorismo: “Gli Usa hanno
un problema di terrorismo in buona parte perché sono strettamente alleati
a Israele, e non il contrario”, sostengono gli autori. E secondo loro,
nulla spiega il sostegno americano a Israele - che dal 1976 è il maggiore
beneficiario di aiuto economico e militare Usa, con circa 3 miliardi di dollari
in assistenza diretta all'anno - se non “l'ineguagliato potere della
Lobby israeliana”.
Con questo termine l'articolo indica l'insieme di gruppi che lavorano per
indirizzare la politica estera Usa in senso filo-israeliano (il termine “lobby”
non ha nulla di negativo in Usa, dove la pressione di “gruppi d'interesse
“ al Congresso è aperta e codificata).
Nessun altro gruppo, fanno notare Mearsheimer e Walt, “è mai
riuscito a trascinare [la politica estera americana] così lontano da
ciò che l'interesse nazionale vorrebbe, riuscendo anche a convincere
gli americani che gli interessi Usa e quelli di Israele coincidano”.
Elencano: l'American Israel Public Affair Committee (Aipac, la seconda più
potente lobby al Congresso); la Conferenza dei presidenti delle Organizzazioni
ebraiche, il Jewish Institute for National Security Affairs, il Washington
Institute for Near Easterns Policy, i Christian Zionists.
Questi gruppi si consultano spesso con i dirigenti israeliani e lavorano perché
la politica Usa sia funzionale agli obiettivi di Israele, dicono gli autori.
Anche se questo poi non è un alleato così fedele: ha consegnato
tecnologie “sensibili” alla Cina, potenziale nemico degli Usa;
ha condotto operazioni di spionaggio contro gli Usa stessi. L'articolo analizza
gli strumenti della lobby israeliana: l'influenza nel Congresso, la capacità
di premiare con fondi e voti i deputati simpatetici e punire quelli contrari;
l'influenza sulla stampa, nelle università. Un'arma “tra le più
potenti è l'accusa di antisemitismo” a chi critica le politiche
israeliane.
La Lobby ha spinto l'amministrazione Bush a scaricare Arafat e sostenere la
politica di Sharon, sempre la lobby “vuole che l'America aiuti Israele
a restare la potenza regionale dominante”. La pressione di Israele e
della lobby è stata “un fattore critico” nell'invasione
dell'Iraq nel 2003, motivata non dal petrolio ma dall'idea di dare sicurezza
strategica a Israele. Ora sono Israele, e la lobby, che spingono contro la
Siria (che pure aveva fornito agli Usa ottima intellicenge su al-Qaeda, notano
gli autori) e contro l'Iran.
L'influenza della lobby, concludono Mearsheimer e Walt, ha reso impossibile
mettere fine al conflitto israelo-palestinese (“cosa che dà agli
estremisti una potente arma di reclutamento”). “Grazie alla lobby,
gli Usa hanno di fatto permesso l'espansione di Israele nei teritori occupati,
rendendosi complice dei crimini contro i palestinesi”. L'unica cosa
buona, concludono i due, è che “gli effetti avversi [della lobby]
sono sempre più difficili da nascondere”.
torna all'inizio della pagina

|
|
| |
TURCHIA / KURDISTAN - BOMBE DI STATO.
L'affaire di Semdinli imbarazza Erdogan.
Kurdistan turco In Turchia la collusione tra stato, pezzi dell'esercito, mafia, polizia è ancora una realtà:
la guerra sporca contro i kurdi non solo non è finita, ma viene combattuta dallo stato con ogni mezzo.
Il caso degli attentati nella cittadina di Semdinli.
(fonte associazione AZAD)
Corpi dello stato scoperti a mettere bombe a Semdinli , una cittada kurda, per accusare il Pkk. L'hanno già chiamata la seconda Susurluk, in riferimento all'incidente stradale che nel 1996 portò alla casuale dimostrazione che la collusione tra stato, pezzi dell'esercito, mafia, polizia era una realtà.
Quello che sta accadendo in questi giorni a Semdinli, paesotto nel sud est della Turchia, ai confini con l'Iraq, mette anche i pochi che credevano che la collusione tra stato, esercito e criminalità fosse cosa del passato di fronte ad un fatto: la guerra sporca contro i kurdi non solo non è finita, ma viene combattuta dallo stato con ogni mezzo.
I fatti sono questi: il 1° novembre una bomba esplode davanti alla caserma di polizia di Semdinli. I feriti, tra i poliziotti, sono 23. Immediatamente l'indice viene puntato contro i guerriglieri del Pkk. Questo naturalmente giustifica l'ultra militarizzazione del territorio, le retate, le perquisizioni, gli arresti. Ma la gente non ci sta e continua a rumoreggiare. Così mercoledì scorso alle 4 del pomeriggio un'auto in corsa getta un ordigno all'interno della libreria Umut (speranza), nel centro di Semdinli. Il proprietario è Seferi Yilmaz, persona molto nota in città: faceva parte, infatti, del commando di guerriglieri del Pkk che sferrò il primo attacco armato contro l'esercito turco, il 15 agosto 1984.
Seferi Yilmaz è stato arrestato poco dopo quell'attacco e condannato a 15 anni di prigione (che ha scontato interamente) per essere membro del Pkk. Mercoledì scorso, come sempre, Seferi era nella sua libreria. L'esplosione è potente. E infatti subito si sparge la voce che Seferi sia rimasto ucciso e un'altra persona che si trovava nei locali, Mehmet Zahir Korkmaz, sia gravemente ferita (si saprà più tardi che Korkmaz è morto). Davanti alla libreria c'è parecchia gente. Immediatamente i passanti identificano l'auto da cui è stata lanciata la bomba, la circondano e cercano di far uscire le persone che si trovano all'interno. Per tutta risposta questi cominciano a sparare uccidendo una persona e ferendone altre 4. Arriva la polizia che si preoccupa di «trarre in salvo» gli occupanti dell'auto. Ma qualcuno tra la folla è riuscito ad entrare nella macchina: quello che trova sui sedili è uno shock per tutti.
Ci sono tre Ak-47 e una carta d'identità rilasciata dalla gendarmeria turca (un corpo dell'esercito). Il deputato della zona, Esat Canan (del partito d'opposizione, Chp) ammette che l'auto appartiene alla polizia di Semdinli. Gli eventi, da quel momento in poi, cominciano a dipanarsi ad una velocità incredibile. Giunge la notizia che Ali Yilmaz, la persona ferita dagli occupanti dell'auto, è morto in ospedale. Tra i feriti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche, c'è anche il sindaco di Semdinli, Hursit Tekin. In serata sono già stati identificati i tre agenti del Jis (il corpo d'intelligence della gendarmeria): si tratta di un sergente e due luogotenenti.
Il governo, inizialmente rimasto in silenzio di fronte alla sequenza di eventi, deve parlare. Lo fa il primo ministro Recep Tayyp Erdogan che dichiara di aver ordinato una inchiesta su quanto accaduto e di volerla seguire personalmente. «Non mi interessa l'identità delle persone coinvolte - dice Erdogan - non ci saranno sconti per nessuno: i responsabili verranno identificati e dovranno rispondere davanti alla giustizia delle loro azioni». È chiaro però che per il governo si trova nell'imbarazzo totale. Intanto a Semdinli il proprietario della libreria Umut, creduto morto, viene invece ritrovato ferito sotto le macerie ma in vita.
Dalla stazione di polizia cominciano ad uscire le prime indiscrezioni sulle confessioni dei tre agenti segreti. Avrebbero ammesso, tanto per cominciare, di essere loro i responsabili dell'attacco del 1° novembre alla caserma di Semdinli. Ma tra i documenti trovati nell'auto gli abitanti hanno rinvenuto anche alcune carte che indicherebbero come in `congedo per un anno' almeno due dei tre agenti segreti della gendarmeria; poi c'erano mappe dettagliate di luoghi e una lista di un centinaio di nomi da colpire, sindaci kurdi, simpatizzanti della causa, sindacalisti. Da tre giorni ormai la città di Semdinli è in subbuglio: per le strade si susseguono manifestazioni di gente che chiede giustizia. Ai funerali dei due uomini rimasti uccisi mercoledì scorso c'è stata molta tensione. Il governo arranca deciso o incapace di fornire spiegazioni.
torna all'inizio della pagina

La Bosnia di Dayton
Appunti per un intervento di approfondimento per discutere della Bosnia di Dayton. Claudio Bazzocchi è ricercatore indipendente dopo molti anni trascorsi nel mondo della cooperazione internazionale. Collabora con Osservatorio sui Balcani fin dalla sua creazione. E' autore di “La balcanizzazione dello sviluppo”, edizioni Il Ponte. Qui di seguito pubblichiamo una sintesi del suo intervento presso il dibattito tenutosi lo scorso 11 giugno a Bologna, aperto ai partners e ai media che collaborano con la redazione di Osservatorio sui Balcani, su: “I protettorati internazionali in Europa: la Bosnia di Dayton”.
Di Claudio Mazzocchi - Osservatorio sui Balcani - 05.giugno.2004
Oltre la dottrina americana di risoluzione del conflitto
In Bosnia Erzegovina ho l'impressione si sia oltre il fallimento della cosiddetta ‘dottrina americana del processo di pace'. E cioè mettiamo i contendenti a firmare, più o meno forzatamente, un trattato di pace e poi il resto in qualche modo verrà da sé. C'è una nuova dottrina che si basa su quello che potrebbe essere definito come fondamentalismo dei diritti umani. Le guerre e le instabilità vengono interpretate come inadeguatezza e mancanza di cultura da parte dei popoli coinvolti.
Questo darebbe il diritto, appunto, alle famose coalizioni dei volenterosi di intervenire per imporre riforme. Dei sistemi giudiziari, dei sistemi istituzionali, della scuola, ecc. Proprio perché si crede che il conflitto, la guerra, l'instabilità esistano perché in qualche modo ci sono popolazioni inadeguate.
Questo darebbe il diritto di intervenire ed imporre… perché i diritti umani - si dice - sono assoluti, non devono tenere conto di nessun processo politico sottostante. Quando un diritto umano viene calpestato allora si può e deve intervenire. Lo si è fatto più volte nei Balcani, basti pensare al Kossovo.
Costruire o decostruire lo Stato?
Una prima contraddizione è quella da una parte di parlare di nation building - cioè di costruzione dello Stato – e contemporaneamente indebolirlo fortemente. Perché se ci si arroga il diritto di licenziare politici, giudici; se si rifanno completamente tutti i sistemi scolastici, economici ecc. non ha senso di continuare a parlare di nation building perché si sta indebolendo lo Stato.
Questa è una contraddizione fondamentale che è all'opera in Kosovo e in Afghanistan, e sarà all'opera in Iraq dopo il 30 giugno. Su questo mi permetto di consigliarvi un libro straordinario, scritto da un ricercatore inglese, si chiama David Chandler, From Kosovo to Kabul (ed. Pluto, 2002). Si tratta di questa scuola inglese di studiosi, tra cui possiamo annoverare anche Mark Duffield ( Guerre postmoderne. L'aiuto umanitario come tecnica politica di controllo . Il Ponte, Bologna 2004), Joanna Macrae ( Aiding Recovery?: The Crisis of Aid in Chronic Political Emergencies , Zed Books 2001), Vanessa Pupavac
(The End of Politics? Therapy against Politics , april 2001). Nel libro di Chandler si sottolinea questa contraddizione. Si opta per l'operazione politica di costruire lo stato ed allo stesso tempo si depoliticizzano tutte le questioni. E' un corto circuito straordinario.
Il Parlamento in Bosnia Erzegovina non decide nulla
Alcuni esempi. In Bosnia la Costituzione non è stata scritta dai bosniaci, le riforme economiche non sono state decise dal parlamento e via dicendo. Il messaggio che trapela più votle dai discorsi dell'Attuale Alto Rappresentante Paddy Ashdown sembra essere questo: alla politica ed alle riforme ci penso io, voi pensate a ratificarle. Se non lo fate? Lo faccio io, ne ho i poteri.
Penso per esempio alla questione delle privatizzazioni. Credo che la BiH, avrebbe tratto beneficio dalla discussione su questo tema da parte dei sindacati, dalle parti sociali, dal parlamento. Non è avvenuto. Queste sarebbero le grandi questioni politiche che permetterebbero di uscire dalle secche del nazionalismo. Ma questo non avviene perché c'è un giudizio quasi neocoloniale sulle popolazioni in oggetto. Personalmente mi sento anche a disagio ad essere qui a parlare di altri.
Uscire dai regimi etnici
Ritengo la questione fondamentale sia come uscire dai regimi etnici. Con una vaga idea di tolleranza, di multietnicità? Oppure passando attraverso questioni forti e politiche? Quella in Bosnia non è stata una guerra in cui erano popolazioni “naturalmente violente”, o classi dirigenti con una cultura inadeguata. Non è stata una guerra perché queste popolazioni non avevano gli strumenti per mediare i conflitti. Piuttosto ci si avvicina di più alle ragioni del conflitto se si pensa che la guerra nei Paesi balcanici sia stata una sorta di aggiustamento rispetto al nuovo quadro internazionale. In cui le classi dirigenti della Jugoslavia hanno individuato nella guerra uno strumento per realizzare forme alternative di statualità, forme alternative di economia, forme alternative di rapporto fra cittadini e potere. Allora, comincio a pensare che non siamo di fronte a folli dittatori barbari e potenti, e quindi il problema è politico. E comincerò a pensare che la retorica dei diritti umani, l'attenzione alle questioni etniche, i programmi di riforma affinché le popolazioni diventino “adeguate”, non funzionano, perché non rispondono a ciò che è successo in quel Paese.
Non è un caso che alle ultime elezioni, non solo in Bosnia, ma anche in Croazia, abbiano vinto i nazionalisti. Non è un caso perché rispetto a questa leggerezza, a questa ideologia dei diritti umani, il richiamo a determinati valori etnici è molto più forte. Perché rispondono non solo ad un bisogno di identità ma anche a determinati problemi economici e sociali. Attraverso i network affaristico- mafiosi, passa il welfare di queste popolazioni, passa lo stato sociale, passano i rapporti di vicinato, passa la sicurezza sia economica che sociale, cioè passa un sistema politico di rapporti fra cittadini e potere.
Perché non si ammette il deficit di bilancio?
Si parla di piccola e media impresa, di rapporto virtuoso fra società civile, impresa, e capitale sociale. Si parla anche di distretti industriali, e il modello sarebbero i distretti industriali italiani. Però, c'è una contraddizione. Il nostro modello di sviluppo economico dell'Emilia Romagna, ad esempio, ha funzionato perché c'era l'ammissione del deficit di bilancio, un cardine delle politiche socialdemocratiche. Cioè si sfora per costruire le infrastrutture ,per costruire un welfare forte, perché tutto questo ci ritornerà in termini di sicurezza sociale, coesione sociale, relazioni fra industria e sindacato corrette e non di tensione, ecc.
In BiH siamo alla più rigida politica monetarista e di inflazione zero, di parità tra moneta bosniaca e euro, questo non permette nessuna politica di deficit di bilancio. Allora siamo alla pura retorica ideologica, rispetto alla piccola media impresa, alla società civile, alla welfare comunity. Stojanov, economista bosniaco, è proprio questo che fa notare: “voi paesi occidentali e soprattutto europei vi siete costruiti su questo modello, perché non lo applicate a noi?
Non dimenticare la storia
Un'ultima cosa: io vedo che quando noi ci troviamo a parlare di queste cose, oltre a parlare sempre di questioni legate ai diritti umani, all'assetto territoriale, alle etnie, parliamo poco o quasi nulla, di quella che è stata la storia della Jugoslava. Non possiamo prescinderne. Non possiamo dire che il socialismo in Jugoslavia è stato un buco nero, per quasi cinquanta anni e adesso concentriamoci sulla ricostruzione, transizione, ecc. Perché, prima di tutto, non è stato un buco nero, nel senso che la Jugoslavia ha vissuto di grandi intellettuali, di grandi correnti politico filosofiche e di un dibattito, all'interno della lega dei comunisti che è stato straordinariamente fecondo, rispetto alla struttura dello stato, ai problemi del socialismo e via dicendo.
Pensiamo in questo senso anche alla visione che si ha delle guerre da noi vissute i prima persona. Su tutti i nostri libri di storia c'è scritto che vi erano delle cause economiche, politiche, sociali e così via. Perché noi non dobbiamo utilizzare questa chiave di lettura anche con la storia non occidentale, tanto più di Paesi vicini a noi che condividono la stessa cultura, gli stessi riferimenti, gli stessi valori?
Si può parlare di transizione?
Concludo dicendo che per questi motivi la nozione di transizione non mi convince. Se ritengo che la guerra e l'instabilità diffusa del dopo guerra siano alcuni degli strumenti per creare un sistema politico sociale alternativo, con una sua razionalità, non posso parlare di transizione. La Bosnia Erzegovina è un Paese dove non si produce niente, ma bene o male, si sopravvive. Si vive di economie sporche, illegali. La nozione di transizione deve essere tolta dal nostro vocabolario quando ragioniamo di questi Paesi ed in particolare della Bosnia Erzegovina.
torna all'inizio della pagina

USA - BROGLI ELETTORALI (PER
NON DIMENTICARE)
Tratto
da Adista Notizie n. 87 - 11 dicembre 2004 e da Internazionale, 23 settembre
2005 di Camille T. Taiara
(basato sul lavoro di project Censored, le venticinque
notizie più censurate dell’anno www.projectcensored.org)
Le elezioni presidenziali
Usa 2004? Una colossale frode ai danni dei cittadini americani, di fronte
alla quale i piccoli "maneggi" della Florida nel 2000 sono state
bazzecole. Nel 2000 Bush vinse in Florida grazie alla Corte suprema, per lo
più repubblicana, che bloccò il riconteggio delle schede perforate
(proprio nel momento in cui Bush era in vantaggio di un soffio). Due anni
dopo, la legge "Help America Vote Act" ha reso la frode elettorale
molto più facile: privatizzazione del processo elettorale e adozione
di sistemi elettronici che non lasciano traccia cartacea. E le quattro compagnie
private incaricate sono tutte legate a Bush. In alcuni Stati, hanno denunciato
numerosi cittadini, l'elettore votava Kerry ma il computer registrava il voto
per Bush; sei deputati hanno chiesto un'indagine formale dopo aver constatato
che alcune macchine contavoto aggiungevano voti inesistenti (93.136 in una
sola contea dell'Ohio). In Florida, si è presentata nell'ufficio elettorale
della contea di Volusia Bev Harris, impegnata da anni sul fronte dei brogli
elettorali. Ha chiesto i nastri originali di ogni macchina, controfirmati
dai funzionari del seggio. Ebbene: dapprima le sono state mostrate copie dei
nastri non firmate, poi, di fronte alle sue proteste, le è stato intimato
di uscire. Ciononostante si è data da fare e ha scoperto sacchi della
spazzatura contenenti i nastri originali firmati. Il risultato è che,
affiancando dati ufficiali e nastri, risultano in tutti i seggi centinaia
di voti in più per Bush.
Infine, la
questione degli exit poll che avevano previsto un vantaggio per Kerry negli
Stati chiave: in tre contee fortemente democratiche della Florida Bush ha
ricevuto tra i 130.000 e i 260.000 voti in più del previsto. E negli
Stati chiave della Florida, dell'Ohio e della Pennsylvania, tutte le differenze
tra exit poll e voto finale erano a svantaggio di Kerry: cosa che può
verificarsi con una probabilità su 250 milioni.
Infatti il 12 novembre 2004 George W. Bush ha battuto John Kerry per tre milioni
di voti, anche se gli exit poll davano il candidato democratico in testa con
un margine di cinque milioni di voti. Questa discrepanza va molto oltre il
margine di errore statistico previsto dal sondaggio, inferiore all’1%.
I principali mezzi di informazione ahanno ignorato che le macchine per il
voto elettronico potevano essere manomesse, così come non hanno parlato
del legame tra i produttori di queste macchine e il partito repubblicano.
Analizzando i dati raccolti dalle due società incaricate del sondaggio,
la Edison media researche e la Mitofsky international, sono emerse prove concrete
di possibili brogli nei conteggi ufficiali. Il margine di errore avrebbe dovuto
essere inferiore all’ 1 per cento, mentre il risultato ufficiale si
allontanava dalle proiezioni di più del 5 per cento. “Gli exit
poll sono molto precisi”, sostengono Steve Freeman, professore del Center
for organizational dynamics dell’ Università della Pennsylvania,
e Josh Mitteldorf, esperto di statistica della Temple University. “Eliminano
quasi tutte le possibili fonti di errore chiedendo agli elettori appena usciti
dal seggio per chi hanno votato. Solo nei distretti in cui lo scrutinio delle
schede era manuale i conteggi ufficiali e i risultati degli exit poll rientravano
nel normale margine di errore. E la differenza tra gli exit poll e i conteggi
ufficiali era maggiore negli “stati in bilico”. Nel rapporto finale,
la Edison meria reserach e la Mitofsky international sostengono che con ogni
probabilità lo scarto era “dovuto al fatto che al sondaggio avevano
partecipato più elettori di kerry che sostenitori di Bush”. Per
quasi tutti i mezzi di informazione questo dimostrava l’accuratezza
dei conteggi ufficiali e la vittoria del presidente uscente.
Nel testo del rapporto, tuttavia, non c’è nessun dato che giustifichi
una conclusione del genere. In realtà il documento dimostra che gli
elettori di Bush che avevano risposto agli intervistatori erano di più
di quelli di Kerry. La differenza tra gli exit poll e i conteggi ufficiali
era troppo ampia per essere spiegata con un errore di campionatura: doveva
esserci stato un errore sistematico. Nei distretti che erano all’ 80
per cento a favore di Bush, la media di errore interna – cioè
la differenza tra le proiezioni degli exit poll e il conteggio ufficiale –
era addirittura del 10 per cento.
Nelle roccaforti di Bush, il candidato democratico aveva ottenuto solo due
terzi dei voti previsti dagli exit poll, mentre in quelle di kerry i risultati
degli exit poll corrispondvano quasi perfettamente ai dati ufficiali.
Nelle elezioni del 2000 non fu calcolato un milione di voti afroamericani.
Kerry ha lasciato che la stessa cosa si ripetesse quattro anni dopo: nel 2004
più di un milione di voti è stato espresso ma non calcolato.
torna all'inizio della pagina |
|